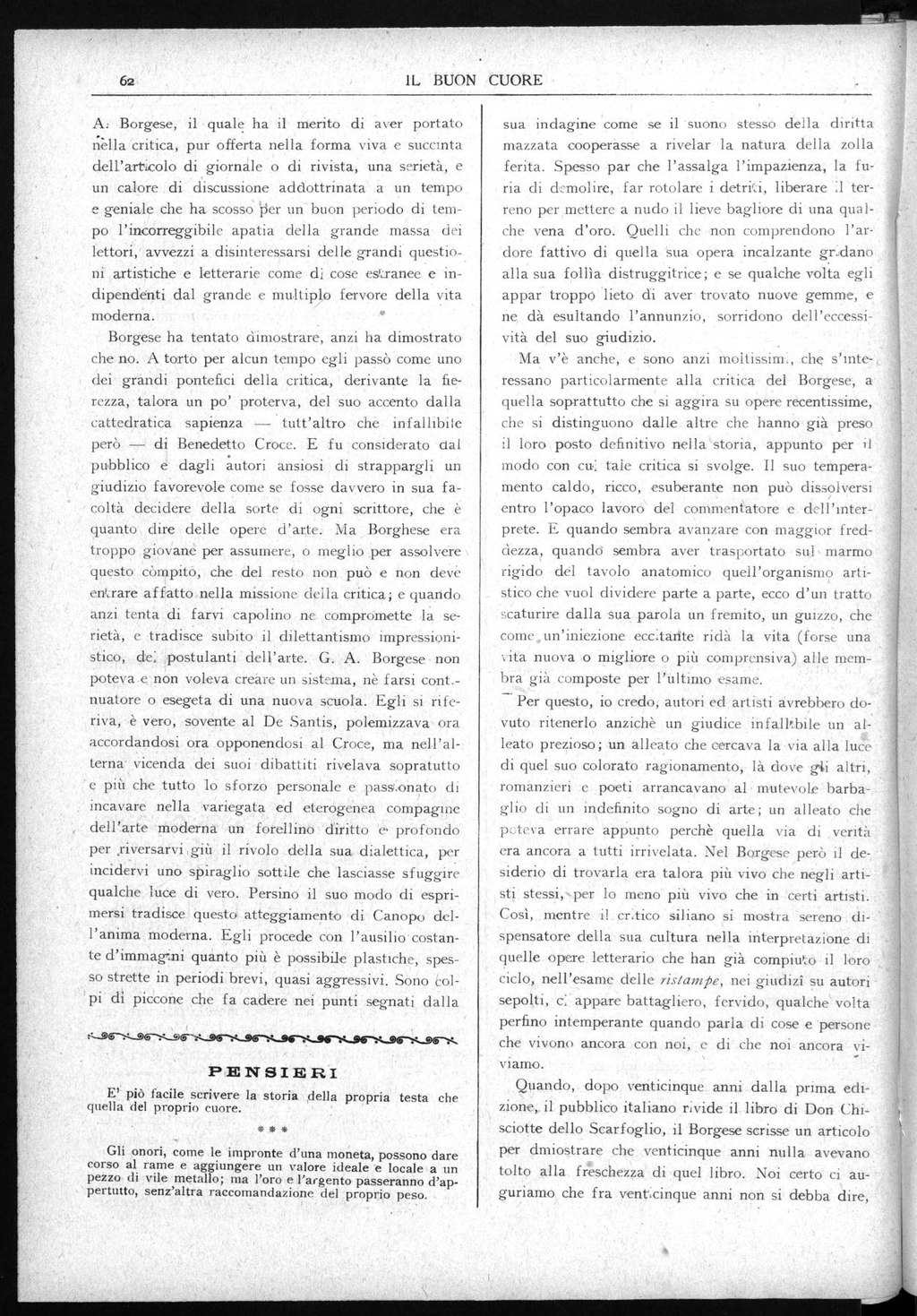| Questa pagina è stata trascritta ma deve essere formattata o controllata. |
A: Borgese, il quale ha il merito di aver portato nella critica, pur offerta nella forma viva e succinta dell’artc. olo di giornàle o di rivista, una serietà, e un calore di discussione addottrinata a un tempo e geniale che ha scosso ìier un buon periodo di tempo l’incorreggibile apatia della grande massa dei lettori, avvezzi a disinteressarsi delle grandi questioni artistiche e letterarie come di cose estranee e indipendenti dal grande e multiplo fervore della vita • moderna. Borgese ha tentato dimostrare, anzi ha dimostrato che no. A torto per alcun tempo egli passò come uno dei grandi pontefici della critica, derivante la fierezza, talora un po’ proterva, del suo accento dalla cattedratica sapienza — tutt’altro che infallibile però — di Benedetto Croce. E fu considerato dal pubblico è dagli autori ansiosi di strappargli un giudizio favorevole come se fosse davvero in sua facoltà decidere della sorte di ogni scrittore, che è quanto dire delle opere d’arte. Ma Borghese era troppo giovane per assumere, o meglio per assolvere questo còmpito, che del resto non può e non deve entrare affatto nella missione della critica; e quando anzi tenta di farvi capolino ne compromette la serietà, e tradisce subito il dilettantismo impressionistico, d’e: postulanti dell’arte. G. A. Borgese non poteva.e non voleva creare un sistema, nè farsi cont.nuatore o esegeta di una nuova scuola. Egli si riferiva, è vero, sovente al De Santis, polemizzava- ora accordandosi ora opponendosi al Croce, ma nell’alterna’ vicenda dei suoi dibattiti rivelava sopratutto e più che tutto lo sforzo personale e passi.onato di incavare nella -variegata ed eterogenea compagine, dell’arte moderna un forellino diritto e. profondo per yiversarvi,giù il rivolo della sua dialettica, per incidervi uno spiraglio sottile che lasciasse sfuggire qualche luce di vero. Persino il suo modo di esprimersi tradisce questo atteggiamento di Canopo dell’anima moderna. Egli procede con l’ausilio costante d’immagini quanto più è possibile plastiche, spesso strette in periodi brevi, quasi aggressivi. Sono Col’pi di piccone che fa cadere nei punti segnati dalla
PENSIERI E’ piò facile scrivere la storia della propria testa che quella del proprio cuore. • *
Gli onori, come le impronte d’una moneta, possono dare corso al rame e aggiungere un valore ideale e locale a un pezzo di vile metallo; ma l’oro e l’argento passeranno d’appertutto, senz’altra raccomandazione del proprio peso.
sua indagine come se il suono stesso della diritta mazzata cooperasse a rivelar la natura della zolla ferita. Spesso par che l’assalga l’impazienza, la furia di demolire, far rotolare i detriti, liberare:l terreno per,mettere a nudo il lieve bagliore di una qualche vena d’oro. Quelli che non comprendono l’ardore fattivo di quella sua opera incalzante gridano alla sua follia distruggitrice; e se qualche volta egli appar troppo lieto di aver trovato nuove gemme, e ne, dà esultando l’annunzio, sorridono dell’eccessività del suo giudizio. Ma v’è anche, e sono anzi moltissimi, che s’interessano particolarmente alla critica del Borgese, a quella soprattutto che si aggira su opere recentissime, che si distinguono dalle altre che hanno già preso il loro posto definitivo nella storia, appunto per il modo con cui tale critica si svolge. Il suo temperamento caldo, ricco, esuberante non può dissolversi entro l’opaco lavoro del commentatore e dell’interprete. E quando sembra avanzare con maggior freddezza, quando sembra aver trasportato sul- marmo rigido del tavolo anatomico quell’organismo artistico che vuol dividere parte a parte, ecco d’un tratto scaturire dalla sua parola un fremito, un guizzo, che come,un’iniezione eccitante ridà la vita (forse una vita nuova o migliore o più comprensiva) alle membra già composte per l’ultimo esame. Per questo, io credo, autori ed artisti avrebbero dovuto ritenerlo anzichè un giudice infalltbile un alleato prezioso; un alleato che cercava la via alla luce di quel suo colorato ragionamento, là dove gli altri, romanzieri e poeti arrancavano al mutevole barbaglio di un indefinito sogno di arte; un alleato che poteva errare appunto perchè quella via di verità era ancora a tutti irrivelata. Nel Borgese però il desiderio di trovarla era talora più vivo che negli artisti stessi,-per lo meno più vivo che in certi artisti. Così, mentre il critico siliano si mostra sereno dispensatore della sua cultura nella interpretazione di quelle opere letterario che han già compiuto il loro ciclo, nell’esame delle ristampe, nei giudizi su autori sepolti, ci appare battagliero, fervido, qualche volta perfino intemperante quando parla di cose e persone che vivono ancora con noi, e di che noi ancora viviamo. Quando, dopo venticinque anni dalla prima edizione, il pubblico italiano rivide il libro di Don Chisciotte dello Scarfoglio, il Borgese scrisse un articolo per dmiostrare che venticinque anni nulla avevano tolto alla fr’eschezza di quel libro. Noi certo ci auguriamo che fra venticinque anni non si debba dire,
•